|
30 luglio 1794
Sotto qualunque punto ci
facciamo a riguardare Teramo sullo scorcio del secolo passato, abbiamo a
compiacercene con vero orgoglio cittadino. Molti dei nostri si dettero
al viaggiare in mezzo a disagi e pericoli che oggi noi ignoriamo. Pochi
viaggiavano per piacere soltanto, i più per istruzione. Fra questi si
segnalarono i Delfico.
Più che discepolo, amico
dell’Abate Quartapelle (1), Orazio Delfico portato da sua tendenza allo
studio delle scienze naturali ed istradatovisi egregiamente in Teramo
nella scuola dell’Abate, fè disegno di portarsi a Pavia allora famosa
pei celebri professori di fama mondiale che vi coltivavano le scienze,
le quali da natura s’informano, di frequentare quello studio e di
conoscere l’Alta Italia. Difatti vi andò nel 1788, vi ascoltò
Volta,
Spallanzani, Mascaroni,
Brusati ed altri sommi, e dopo d’aver percorso l’Alta Italia col
Quartapelle e con lo zio Melchiorre se ne tornò a Teramo nel 1791.
Giovane ardente teneva
dietro a tutti i nuovi studii ed alle loro applicazioni: Di quegli anni
lo scienziato De Saussure saliva le Alpi e tentava il gigante monte
Bianco De Luc preparava strumenti per misurarlo con altro metodo che il
geometrico già antico. Anche egli concepì il disegno di fare altrettanto
pei suoi monti Abruzzesi.
Appena tornato in patria
nella bella stagione insieme col Quartapelle (2), il Comi, il Michitelli
fin dal ’91 percorse buona parte delle valli e delle falde della nostra
catena appennina. Studiò molte sorgenti, molti minerali, piante ed
animali. Con tali studi e tali applicazioni si rivolse al Gran Sasso. Fè
proposito di salire all’ultima vetta e misurarne l’altezza (3). Molti
ostacoli dovè vincere intorno a sé, ma ebbe la fortuna di trovasi
attorno persone colte della forza di un Melchiorre e vide gli ostacoli
convertirsi in aiuti. Or, mosso dalla curiosità naturale dell’uomo e che
forse più d’ogni altro senso interno, scrive lui, contribuisce ad
accumulare nello spirito umano gli errori e la verità, e sollecitatovi
precedentemente dal dotto illustratore della geografia del Regno sig.
Giuseppe Galante, il 25 luglio del 1794 si partì da Teramo. Però prima
di partire aveva incaricato l’architetto Eugenio Michitelli, suo cugino
ed altro nostro egregio concittadino, di fare le osservazioni
barometriche in Teramo in corrispondenza con le sue ed a Ornano in casa
del sig. Luigi Petrilli che co' suoi figli gli fu utile scorta e
compagnia alla salita. Dopo quattro giorni di preparazione, il dì 29
alle ore 11 e tre quarti pomeridiane mosse alla volta del Gran Sasso con
i suoi ospiti, domestici ed altra gente del luogo che avevano pratica
della montagna; e dopo il cammino di circa quattro ore giunse ad Ara
Pietra. Fin qua su muli, quindi a piedi e, dice, a stento e adagio
andando avanti giunse in un esteso ripiano quasi interamente circondato
da alte roccie che ne formano come una maestosa conca. Da qui montò dal
lato orientale alla più alta cima o, come egli scrive, all’ultima
cimata, un piccolo piano inclinato quasi fosse un coverchio, o un gran
lastrone ivi sopra imposto di massa uniforme della pietra istessa e, che
servì pure di letto a tutta la compagnia.
Da Ara Pietra all’ultima
cima che era il lato orientale del Corno Grande e che toccò verso le tre
p. m. del 30 impiegò un undici ore di salita e alle quattro e mezzo ne
cominciò la discesa, se meno disagiata, non meno pericolosa della
salita. Fece molte osservazioni sulla natura della sostanza o l’origine
della montagna, sul ghiacciaio, sul suo fonte che scorre sul gelo e cita
i versi del Pontano nel libro De fontibus et fluminibus (4).
Un barometro e due
termometri porta seco e altrettanti (5) ne lascia in Teramo al suo bravo
e dotto cugino Eugenio Michitelli. Seguendo il sistema De Luc fanno
osservazioni barometriche a Teramo, ad Ornano e sulla cima del lato
orientale, ed hanno l’altezza del Gran Sasso in 9577 piedi parigini.
Fece molte altre
osservazioni scientifiche, preziose per la maggior parte anche oggi per
la loro profondità e per ragione del tempo e del luogo. Già molte ne
aveva fatte prima insieme col valente chimico Dottor Comi e col
Prof. Quartapelle, ma per farne altre ancora, non potendo
quell’anno, vi tornò l’anno appresso alla metà di luglio in compagnia
del Michitelli. Rimase ad Ornano fin l’undici agosto per le esplorazioni
attorno. Al 12 partì dall’ospitale paese per trovarsi allo spuntare del
sole sulla montagna di Vado, passò alla montagna delle Tre
Torri. Gittò lo sguardo al Fosso del mal passo e allea
voragine sotto il nome di Inferno di S. Colomba. Non sfuggirono
alla sua osservazione i fenomeni delle Gravure prodotte dai
grandi massi rotolanti di neve. Per la montagna di Forca andò a
Pietracamela, e si appressò alla montagna d’Intromesole
visitandovi la grotta della vena dell’oro. E qui fu il termine
del suo penoso cammino. Fece replicate analisi chimiche, si convinse
che i nostri monti non possono darci che ferro e notò la vera ricchezza
di carbon fossile e di legname di ogni specie.
Tutto egli raccolse in
una lunga lettera diretta in Napoli al suo zio materno, Marchese Filippo
Mazzocchi e, col titolo di Osservazioni su di una piccola parte degli
Appennini, pubblicò a Milano nel 1796 ricca di una tavola per la
misura dell’altezza e di due vignette del Gran Sasso designate
dal Michitelli prima di giungere al Castello di Fano.
Questa pubblicazione fu
il primo lavoro scientifico fatto sul Gran Sasso d’Italia e tenuto in
molto conto dai dotti fin dal suo apparire alla luce e prese il suo
posto accanto ai Viaggi per le Alpi del celebre M. De Saussure.
Esaurita la prima stampa
e richiesta dai dotti e avendo osservato che il naturalista tedesco
Reuss e quindi Scipione Breislak nella sua geologia avevano data misura
inferiore del Monte Corno, il padre di Orazio la fece ristampare
nel 1812 in appendice della sua storia d’Interamnia
Pretuzia (6).
In fine, il Club
Alpino Italiano la inserì nel numero 18 del suo Bollettino. Così
dell’opera del Delfico possiamo contare tre edizioni e rilevarne il
valore e l’importanza (7).
Ecco in iscorcio la
memoria odeporeca del Delfico; ora possiamo al centenario a suo onore
celebrato dai posteri e specialmente da Teramo, sua terra diletta.
II
30 luglio 1894
Anche dopo un secolo
l’ascensione fatta dal Delfico vive nella memoria dei posteri e
seguiterà a vivere in altri ancora. Il che si deve specialmente alla
stampa della memoria. L’azione passa e la stampa rimane. Per essa dopo
De Saussure poniamo il Delfico, come dopo le Alpi, gli Appennini. Così
incomincia la storia delle salite e delle montate ardite alle vette più
sublimi del
bel
Paese che Appennin parte e …..circonda l’Alpe.
Oggi non evvi chi non
comprenda la grande importanza per la storia e la geografia e in
generale per la coltura speciale di questa e quella regione le
escursioni montanine. Il
Club Alpino
Italiano con le sue escursioni e le sue pubblicazioni ha molte
benemerenze nella letteratura nazionale moderna; e più ne avrà quando
crescerà di socii e quando vedrà effettuati i suoi disegni onde dagli
altopiani, dalle praterie, dai boschi e dalle alte vette rifluisca onda
salutare di vita forte in mezzo alle popolazioni sparse per valli e
piani più comodi dei monti, ma non sempre egualmente sani. Il Club
Alpino comprese l’importanza dell’escursione fatta dal Delfico e ne curò
la ristampa nel suo Bollettino. Ora ne celebra il centenario e il
presidente comm. Malvano il 10 luglio di quest’anno manda il seguente
invito a tutti i socii Alpinisti Italiani:
Egregi
Colleghi,
«Il 30 luglio 1794
Orazio Delfico compieva la prima ascensione della vetta orientale del
Corno Grande del Gran Sasso d’Italia e ne scriveva una importante
memoria che avrete letto ristampata nel Bollettino del Club Alpino
Italiano, n. 18.
«A commemorare la
fausta prima ascensione della più elevata vetta dell’Appennino questa
Sezione ha deliberato una escursione invitandovi i colleghi di tutte le
sezioni. Siamo quindi lieti di rivolgerci a voi, che sapete vivificare
lo spirito e ritemprare la fibra sulla pura aura dei monti, per
incitarvi a venire con noi a commemorare chi, quasi nell’epoca stessa in
cui De Saussure ascendeva ed illustrava la vetta più elevata delle
Alpi, sapeva vincere l’inconsulto terrore che anche nelle popolazioni
meridionali inspiravano i monti, e superava e scientificamente
descriveva il gigante degli Appennini.
«Non v’invitiamo a
feste, ma ad un semplice amichevole convegno, ad una semplice escursione
che, quanto più numerosi sarete, tanto più raggiungerà lo scopo di
dimostrare la nostra gratitudine verso coloro che furono i nostri
precursori ed anche i nostri ispiratori.»
E i socii risposero in
gran numero all’invito del Malvano. Ma lasciamo al Bollettino del Club
Alpino discorrere dell’ascensione di quei che partiti da Roma per
Aquila, Assergi, il Rifugio, ascesero al Gran Sasso, e prendiamo nota
dei due drappelli che partiti da Teramo salirono alle più alte cime del
Gigante dormente.
Questa volta il Gran
Sasso davvero come rocca, e che rocca ! è stato preso d’assalto da più
punti. Un drappello di giovani Teramani per Montorio si portarono il 29
luglio a Pietracamela, ove furono ospiti graditi, come sempre dei
signori Dionisi, e di qua mossero rimontando il rio Arno, ricco d’onde
cristalline e di sponde meravigliose e per Campopericoli pervennero al
Rifugio. Parte rimase a Pietracamela, parte al Rifugio, si
assottigliò così il drappello, tanto che solo in numero di tre, Fausto e
Luciano Delfico e l’Avv. Flaviano De Marco, con una guida seguirono gli
Alpinisti di Roma e salirono al lato occidentale e all’orientale
raggiunto da Orazio Delfico.
Un altro drappello mosse
anche da Teramo e coll’intenzione di seguire lo stesso sentiero battuto
da Orazio Delfico: onde fece la prima sosta ad Ornano anche a casa
Petrilli ed ebbe liete e festose accoglienze dal Dott. Raffaele,
pronipote del Petrilli che fu ospite e compagnoni Orazio al Gran Sasso.
Egli volle essere del drappello ed ascendere il monte. Quindi
accoglienze non meno liete il drappello ne trovò ad Isola del Gran Sasso
in casa De Plato che provvide di muli e mulattieri, di guide e
vettovaglie la brigata.
Qui, fermatisi alcuni
venuti da Teramo, si costituì il drappello di 10 persone, di quattro
alpinisti di occasione, il Prof. Giacinto Pannella di Teramo, il Dott.
Raffaele cav. Petrilli di Ornano, Giovanni De Plato e Fileno De Amicis
d’Isola del Gran Sasso, giovani che hanno ereditato dai padri passione
ardente pei monti, di due guide e di quattro robusti pedoni, e mosse da
Isola alle 11 e tre quarti del 29. Costeggiando sempre a monte la sponda
sinistra del risonante Mavone passò per Cesa di Francia, Forca di Valle,
Vena spaccata, Forchetta ove fa sosta di un’ora e alle 6 pervenne ad Ara
Pietra e poco dopo incominciò la salita del Vallone.
In Ara Pietra, a 1727
m., siamo al vestibolo dei due Corni. Qui lo spettacolo è
meraviglioso. Distese di terre a perdita d’occhio cinte dal mare; ma
questo spettacolo cresce a dismisura alla cima del monte. Noi immersi
ancora nella penombra del bosco di Forca di Valle, già il sole indorava
le alte cime della catena e spiegava la luce verso noi di mano in mano
che montavano. Questo contrasto di ombra e di luce pasce l’occhio e la
fantasia nelle grandi ombre dei faggi proiettantisi alle falde vede
tanti giganti che danno l’assalto al Gran Sasso, a quest’Olimpo dei
popoli Pretuziani. Dal nevaio alle sorgenti del Mavone si apre ampio
vallone tra i due Corni; i gran massi accavalcantisi ne costituiscono i
gradoni. A destra il Corno Piccolo, a sinistra il Grande, sembrano con
le loro pareti ferrigne e qua e là anzi di bronzo avere per volta il
cielo e terminarsi alla rotonda del ghiaccio. L’occhio vede tanto e la
fantasia l’accresce; ma le piante dei piedi e spesso le palme delle mani
toccano che i gradoni sono massi su massi che fanno serpeggiare e andare
su e giù faticosamente.
Dopo un’ora si giunse
alla Grotta delle Cornacchie coll’adito ad un tre metri su le
pareti del Corno Piccolo: è un antro naturale, vaneggiante entro il
masso. Poco più su a destra presso le pareti del Corno Grande, un
poggetto fiorito circondato da massi e da neve si eleva l’accampamento
di Saint-Robert. E si sale e si sale e i massi diventano più
piccoli; un’altra ora di salita, si posa i piedi sulla ghiaja, che
spesso al muovere dei passi scorre a torrenti e fa precipitare a valle:
è la zona del ghiaieto, il brecciaio faticoso; ma ne alletta la vista
maestosa della conca, del Calderone. Là entro si dimentica ogni
stento, ogni pericolo corso. E’ una basilica maestosa che da mezzo il
cielo l’illumina la lucerna del mondo; attorno attorno le pareti del
nevaio sono colonne qua lisciate dal gelo colante, là a tortiglione, più
avanti striate o serpeggianti a capriccio del fulmine e del genio delle
tempeste; tappeto soffice e gentile, la neve copre il pavimento, solcato
in mezzo da limpido ruscello che scorre su letto di gelo e si versa in
un laghetto di ghiaccio quale di fino cristallo per ricomparire in
cascatella fuori del nevaio a lato del brecciaio. Anche lassù una festa
di colori: accanto al variopinto dei fiorellini, il candido della neve,
il ferrigno e il bronzino delle pareti riflesso nell’iride del ruscello,
e tutto illuminato dal più fulgido sole di luglio. Guardando attorno
fino ai pinnacoli delle cime con lo sguardo vagante si va in cerca del
nume titolare del luogo donde scesero le prime genti italiche a popolare
i piani sottostanti.
In questo luogo
incantevole e sublime muore ogni passione e non vive se non quella
altera dei monti, e la presenza dell’uomo anima tutta la scena e porta
vita su vita.
In questa rotonda che
guardano come scolte i due lati, orientale ed occidentale, delle due più
alte cime s’incontrarono ad una stessa ora, le dieci del giorno 30, i
tre drappelli, quello di Roma e i due di Teramo; e mentre un quarto si
affacciava sulla cresta del lato occidentale, si salutarono, si
strinsero fraternamente la mano e, raggianti i volti di gioia,
acclamarono fra gli evviva Orazio Delfico.
Ma le guide ci
sollecitano a salire alla cima raggiunta dal Delfico perché vagolano a
basso nei valloni figure fantastiche di nebbia. Alle 11 siamo alla
sommità e posiamo sul piano inchinato, sul lastrone, prima del
Delfico non calcato forse mai da orma umana.
Ogni peso di stanchezza
è scomparso, si depone buona parte del fardello degli anni né rimane
traccia dei disagi patiti; la vista che spazia sublime lontano, lontano
attutisce ogni altro senso; gode l’animo nostro della natura doma fin
lassù. Se guardar dall’alto in basso è di spirito altero, solo al sommo
del Gran Sasso quell’alterezza sembra congenita al misero figlio
d’Adamo. Lassù non si parla o poco, si guarda, si mira e rimira e si
ritorna a guardare e rimirare. Lo sguardo non si può staccare dagli
altri monti allineati e degradanti a destra e a sinistra, dalle distese
di terre a perdita d’occhio cinte da mare al nascere e al morire del
sole.
Il lastrone, il
piano inchinato, lassù ricorda Delfico e, monumento che non
passa, lo indica all’Alpinista. Il Conte de Saint-Robert fece staccar
piccoli massi intorno al piano inchinato, ne fece fare un
mucchietto d’un due metri, segno anche lassù della signoria dell’uomo
sul resto della natura. Ora tra pietra e pietra del mucchietto si
lasciano ricordi. Il cartoncino sigillato entro cilindretto di cristallo
ricorda il centenario, il cammino battuto e chi vi pose il
ricordo:
ORAZIO DELFICO, 30 LUGLIO 1794
GIACINTO PANNELLA, 30 LUGLIO 1894.
TERAMO, ORNANO, ISOLA, ARA PIETRA,
NEVAIO, CORNO GRANDE.
Altri vi lasciarono
altri ricordi.
Gittati de’ razzi in
alto, dato fuoco in segno di festa a castagnole, alle 12 si scese
rifacendo gli stessi passi. Alla Conca, al luogo incantevole, la
comitiva riunita fè di nuovo sosta, propinò ad onore di Orazio Delfico e
fu fotografata dall’Avv. De Marco. Tutti giulivi, giù pel brecciaio, giù
pel vallone, ad Ara Pietra alle due per ritornare che a Pietracamela e
chi ad Isola ed Ornano. Il centenario, tanto pel numero degli alpinisti,
tanto per l’ascensione da tre diversi punti e ai due lati del Grande
Corno, quanto per la bella giornata, non poteva meglio celebrarsi e fu
degno degli Alpinisti, del Delfico e di Teramo sua terra.
Ma quel che abbiamo
fatto e scritto è passato e per le ricordanze. Aggiungiamo qualche cosa
pel presente e per l’avvenire.
Tante questioni, piccole
e grosse, economiche, sociali devesi andare a sciogliere ai monti ed ai
mari. Se si pensasse ad essi, tante miriadi di disoccupati turbolenti
troverebbero il loro posto lungi dai paesi e dalle città delle valli e
dei piani.
E da madre natura
l’Italia ha ricevuto a dovizia di mari e di monti per luogo ai suoi
figli e farli vivere in sede tranquilla. Parallele alle navi da guerra
devono solcare i mari le navi di commercio. Guardiamo alle navi di
Francia, d’Inghilterra e degli Stati Uniti. L’Italia ha costruito quelle
della prima specie, deve ancora le altre della seconda.
Ma lasciamo questa volta
ondeggiare il mare e tuffarvi le migliaia di bagnanti e restiamo ai
monti non meno salutari in questa stagione. Finora i paesi presso alle
falde non hanno che recato male ai monti denudandoli delle piante e
impedendo il crescere dei boschi con greggi esuberanti di bestiame. Ora
in parte il Governo va impedendo questi mali, ma altro dovrebbe fare.
Molto dovrebbero fare i Comuni limitrofi ai monti.
Ecco poche parole
nell’intento di favorire le ascensioni al Gran Sasso dal lato orientale,
singolare per le bellezze meravigliose.
Il Club Alpino Italiano
alle altre benemerenze deve aggiungere anche questa di costruire un
Rifugio ad Ara Pietra (8); coi due rifugii può attuare il disegno
dell’Astronomo Tacchini impiantandovi una specola.
I Comuni dalla parte
loro dovrebbero non lasciare in abbandono delle intemperie i sentieri
anzi, costituiti in consorzio, aiutati dalla Provincia, dovrebbero
costruire strade carrozzabili movendo da Tossicia o da Ornano, o da
Isola, sino al rifugio. I Comuni alle falde, i proprietarii, signori di
praterie e boschi, devono fondare case alla svizzera a piè e a capo dei
boschi, in mezzo alle praterie.
Si deve costituire una
sezione Alpina della Provincia Teramana. Alcuni amatori di monti hanno
pronto uno schema per costituirla. La costituirebbero socii effettivi ed
onorari. Tutti i sindaci dei Comuni limitrofi ai monti sarebbero socii
onorarii e presidente onorario il sindaco di Teramo. Meglio e con minore
spesa il Governo potrebbe conservare, anzi accrescere i boschi e
regolare il taglio e la coltura delle piante. Dall’altro canto i Comuni
potrebbero far consumo razionale di legna pur conservando la loro
proprietà boschiva. Ma bisogna fare strade e costruire case per rendere
possibile il soggiorno salutare dei monti anche a cittadini, usi ad
altra vita.
Per tre stagioni
dell’anno, la Sezione Romana, la futura Sezione Teramana degli
Alpinisti, il Governo, i Comuni montagnosi, i proprietari e tutti gli
amatori dei monti devono invitare a salire e soggiornare alle falde ed
ai fianchi, alle praterie ed ai boschi, con escursioni ed ascensioni
fatte ora a diletto, ora a diletto ed istruzione insieme, sempre a
salute.
Con la costruzione delle
strade, del Rifugio, delle case veramente montane si riuscirebbe a far
sostituire a molti il soggiorno delle falde dei monti a quello delle
spiaggie dei mari oggi troppo affollate, e a far risparmiare ad altri
l’andata assai costosa su i monti toscani e gli svizzeri più lontani.
Alcuni credono abitare i
monti facendo stanza in qualche paese a questi vicino, ma presto si
trovano a disagio e non raggiungono lo scopo; in quella vece bisogna
montar su, su, vivere circondati di cespugli, in mezzo ai castagni, agli
abeti, ai faggi, e respirare di notte e di giorno i profumi emananti dai
fiori delle praterie e dalle piante delle selve vergini, lungi, lungi
dai rumori della solita vita e dagli altri dei soliti luoghi popolosi,
per vivere vera vita montanina.
Con le andate, con le
salite, con le escursioni ai monti ne verrebbero la conoscenza più
particolare e lo studio compito dell’intero gruppo dal Tronto alla
Pescara; e si sa quanto ricca fonte di sapere sono i monti. Questi ed
altri effetti benefici alla salute e al sapere compenseranno ad usura la
spesa.
Parte della nostra
provincia potrebbe essere la Svizzera Italiana: le doti di natura non
mancano, manca l’opera dell’uomo.
Non aggiungo parola
perché evidenti sono le necessità e l’utilità di fare qualche cosa e di
trarre profitto dai monti che ingombrano tanta parte della nostra
Provincia.
|
|
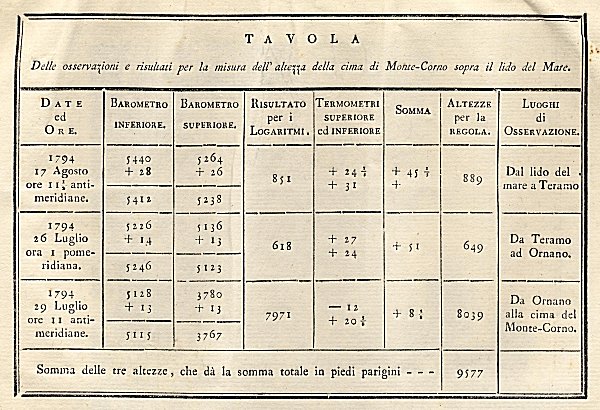 |
Tavola delle
Osservazioni e dei risultati per la
misura dell'altezza della cima di Monte Corno sopra il
lido del Mare
|
|
|