|
E' l'inno che percorre durante tutto l'Ottocento una terra parcellizzata da
secoli di divisioni politiche; è il grido scaturito dallo slancio di generazioni
che si avvicendano condividendo prima gli eroici tentativi di riscatto, poi
l'orgoglio di aver ricondotto ad uno ciò che per natura (tratti fisici,
linguaggio, discendenza) è tale; è l'invocazione "di un volgo disperso che
nome non ha" (1) e che tende a recuperare le radici della propria identità.
I motivi umani e politici di quest'epoca trovano nella letteratura e nelle arti
quel privilegiato canale di diffusione che nella trasfigurazione poetica,
narrativa, musicale e pittorica compie una traslazione del tema della nazione
dalla sfera istituzional-politica all'ambito, per così dire, "popolare". La
coscienza di nazione probabilmente non si sarebbe ingenerata nella gente comune
senza l'efficacia evocativa di quest'etica che le arti le hanno potentemente
impresso. "In tal modo il discorso nazional-patriottico potè avere una presa
e un successo di pubblico che, per la natura dei media, gli sarebbe stato negato
quando fosse stato affidato esclusivamente al classico trattato politico […]
Insomma, una tragedia, una poesia, un romanzo o un'opera lirica potevano più
facilmente toccare corde profonde nell'animo di un numero incomparabilmente
maggiore di fruitori, di quanto non fosse mai stato possibile per un freddo e
distaccato saggio analitico" (2).
Un motivo percorre l'intera penisola; un tema dato, che serpeggia
contrappuntisticamente tra le voci multiformi che sorgono a cantare libertà,
unità, fratellanza. E' il "canone risorgimentale" (3) il cui canto, con eco
appassionata, colora di sé, a intervalli di tempo, di luoghi, di ceti sociali,
il vivere. Così, la galleria di coloro che definiamo con riverente indicazione
"padri della Patria" è affollata di una moltitudine di uomini - e di donne -:
politici, intellettuali, letterati, musicisti, artisti. Volti e nomi più o meno
noti, tutti egualmente fautori e partecipi di questo anelito unitario. All'arte
dunque, il compito più difficile in quanto il più alto: sublimare le reali e
pressanti necessità economiche e sociali, infondendo la consapevolezza che la
salda comunanza di "nazione"rende forza alla fragile individualità di un
semplice "popolo"; ad essa, attuare il fine ultimo del messaggio mazziniano
costantemente rivolto alla promozione "di un popolo che sceglie di agire e di
fondare se stesso come nazione" (4). All'arte ancora, affidare il proprio
"risorgimento" e quello italico, nella misura in cui essa stessa, affrancata da
semplice perfezionamento di metodo e da povero ornamento, va a perseguire i suoi
più alti destini.
"Manca alle arti, alle scienze, a tutte le dottrine chi le rannodi. Manca chi
le concentri tutte a un intento, e le affratelli in un pensiero di civiltà.
Manca e verrà. […] Chi ha mai levata una voce che dicesse, non ai maestri
incorreggibili sempre, ma a' giovani che vorrebbero lanciarsi e non sanno come:"
L'Arte che trattate è santa, e voi, dovete essere santi com'essa, se volete
esserne sacerdoti. L'Arte che v'è affidata è strettamente connessa col moto
della civiltà, può esserne l'alito, l'anima, il profumo sacro, se traete le
ispirazioni dalle vicende della civiltà progressiva, non da canoni arbitrarii,
stranieri alla legge che regola tutte le cose […]?" (5)
Le parole di Mazzini riferite immediatamente alla musica sono assimilabili –
come peraltro asserito dallo stesso uomo politico – a tutte le attività
artistiche, che trovano la loro massima realizzazione nel compimento di un
progetto morale. Testi come questo educano e accendono gli animi delle giovani
speranze del Risorgimento italiano. La letteratura patriottica di Leopardi, di
Foscolo, di Manzoni, di Pellico; i melodrammi storici di Rossigni, di Mercadante,
di Bellini, di Donizetti e di verdi avviano e/o sostengono la costruzione di
quell'idea di nazione che le inevitabili dolorose rivolte suggelleranno
nell'unità nazionale.
Autori "minori" accanto a quelli appena ricordati e ben più frequentati, fanno
proprio l'assunto mazziniano raccogliendo l'invito a rendere la loro arte
veicolo di espressione di una fede sociale. Scevri da semplici "atti d'ossequio"
o da "buffonate imposte" (Liszt), numerosi artisti, con sincero e personale
sentire, cantano i motivi della fede in quel comune ideale "[…] di libertà
che rende Religion più viva; che il patrio amore accende, ma impone fedeltà"
(6).
Si giunge così a considerare il coinvolgimento di alcuni personaggi della storia
teramano nelle vicende politiche dell'epoca risorgimentale. Tre nomi si
ricordano tra gli artisti che hanno dato voce, suono, spirito e colori al fitto
contrappunto del "canone risorgimentale": il musicista Luigi badia (1819-1899),
la poetessa Giannina Milli (1825-1888) e il versatile Melchiorre De Filippis
Delfico (1825-1895) fine e arguto caricaturista del mondo musicale e politico
coevo.
Di Luigi Badia occorre immediatamente ricordare due rappresentativi lavori
politici: le cantate L'Italia del 1847 e il 29 gennaio 1848 e La
costituente italiana, risalenti a un periodo di profondo impegno patriottico
vissuto in prima persona con l'arruolamento nel Battaglione dei Volontari
napoletani stanziato a Firenze con il quale Badia combattè diverse battaglie tra
cui quella di Curtatone. Ma il tema dell'amor patrio, se viene abbracciato nei
trionfalistici momenti in cui la speranza politica si infiamma, non viene
dimenticato neppure quando il compositore sarà fisicamente lontano. Le pagine di
numerose romanze – genere salottiero, per sua natura intimista spesso frivolo e
spensierato – si accendono rivelando ancora un profondo impegno culturale e
politico: la poesia si fa epica, la romanza per voce solista si amplifica in un
afflato corale; la generazione di artisti, di poeti, di cantanti, la generazione
dei compagni di battaglia che hanno offerto per un ideale la loro arte, la loro
affermazione personale e la loro vita, rivive.
Se Badia offre un canto, Giannina Milli presta al pensiero risorgimentale le sue
apprezzate facoltà di improvvisatrice conferendogli forma poetica. Così, la sua
prima raccolta del 1848 comprende oltre ai versi intimi sulla sua vita e sui
suoi studi, numerosi componimenti destinati a celebrare i primi casi delle lotte
per l'indipendenza nazionale (7). Ambasciatrice infaticabile di tali sentimenti
anticipa idealmente l'unità d'Italia percorrendola da Napoli a Roma, dalle
maggiori città del Granducato di Toscana a Milano, da Bologna a Torino, senza
dimenticare i suoi viaggi in Sicilia e in numerose altre località del sud
Italia, dove fa riecheggiare versi dedicati a valorosi patrioti (8); intesse
rapporti con una fitta schiera di intellettuali e politici; offre conforto e
protezione ad esuli e perseguitati politici (9).
Gli accesi toni del Risorgimento infine, si colorano di sarcastica vivacità
nelle caricature di Melchiorre De Filippis Delfico: Piccole tavole a colori
accolgono il "canone risorgimentale" con elegante arguzia: personaggi, citazioni
letterarie e musicali, situazioni geo-politiche, trovano immediata ed efficace
espressione in numerosi bozzetti recanti pungenti didascalie. Se ne ricordano
solo un paio per esigenze di brevità: "Quartetto Rigoletto", in cui la
citazione verdiana "bella figlia dell'amor schiavo son dei vezzi tuoi"
(Rigoletto – Duca, atto III, scena I) in bocca a Napoleone III che tiene in
braccio le due neonate francesi Nizza e Savoia, ben evidenzia i patti di
cessione dei due contadi alla Francia in cambio dell'aiuto ottenuto dai Savoia
nella II guerra d'indipendenza che gli ha guadagnato la Lombardia; "Serenata"
in cui Giuseppe Garibaldi alla chitarra, attorniato da tutte quelle città e
regioni che hanno trovato l'unità, canta a Venezia – ancora sotto il dominio
austriaco – "Ecco ridente in ciel spunta la bella aurora e tu non sorgi
ancora e puoi dormir così?" (G. Rossini, Il barbiere di Siviglia –
Almaviva, atto I, scena I) (10).
Allo svolgimento di questa iniziativa il compito di una riflessione critica più
approfondita e attenta di quanto queste brevi note abbiano potuto anticipare.
|
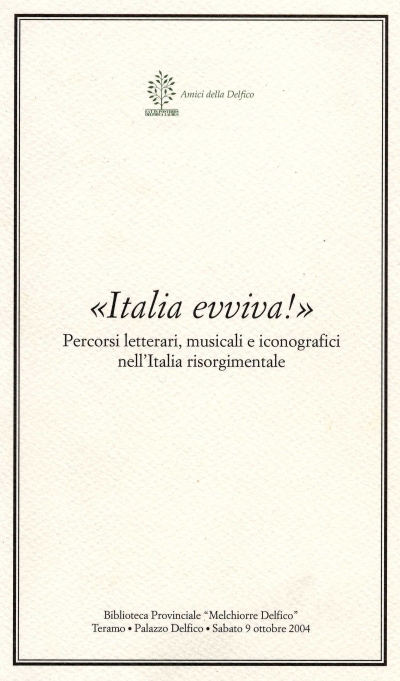 |
|
«Italia evviva!» Percorsi letterari,
musicali e iconografici nell'Italia risorgimentale |
|
|