|
Il cinema Olimpia in Castellamare Adriatico |
|
|
|
di Luciana D'Annunzio |
|
|
|
Castellamare Adriatico, nei primi anni successivi all’unità
d’Italia, epoca della costruzione della linea ferroviaria
adriatica, era un borgo collinare ed agricolo del circondario di
Città S. Angelo, in provincia di Teramo, gravitante attorno alla
chiesa della Madonna dei Sette Dolori e, successivamente unito a
Pescara a seguito della costituzione della nuova provincia,
avvenuta il 2 gennaio 1927. L'economia del piccolo centro rimase
a lungo del tutto legata alla realtà rurale fino al
1863
quando, alla presenza del
re
Vittorio
Emanuele II, fu inaugurata la
stazione ferroviaria
della quale
quest’anno ricorre il 150° anniversario.
La presenza dello scalo ferroviario favorì la libera nascita di
un mercato giornaliero tanto che l’amministrazione comunale
decise di trasferire, nei pressi della stazione, il mercato
domenicale che si teneva a Villa Muzii. Si costituì in tal modo
il primo insediamento di quella che sarà successivamente
definita Piazza del Mercato e poi del Sacro Cuore, a seguito
della costruzione della chiesa, aperta
al culto nel 1900 ancora incompleta, per sostituire la piccola
chiesa di S. Anna, sita all'interno di Villa Muzii,
diventata ormai insufficiente a fronte di una comunità che
cresceva rapidamente.
Nell’arco di qualche decennio la zona compresa tra la stazione
ed il mare prosperò notevolmente e fu ampiamente edificata
determinando sia una veloce e non pianificata urbanizzazione del
territorio, quanto il decisivo impulso dello sviluppo
commerciale, residenziale e turistico con l’organizzazione dei
primi impianti balneari.
Tale fermento fece sì che si pensasse anche alla realizzazione
di una seppur ridotta struttura teatrale. A questo proposito il
settimanale Il Faro del 27 gennaio 1910 riportava la seguente
notizia: "Procedono alacremente i lavori della nuova ed ampia
sala per cinematografo e per concerto, che sorgerà al lato est
della Piazza del Sacro Cuore in Castellamare, a cura dei signori
Di Silvestro e Di Michele. La magnifica sala sarà decorata con
la ben nota abilità dal distinto prof. Di Silvestro. E’
provvista di un comodo foyer, ove sarà collocato un
bar; in fondo vi è un gran palcoscenico e intorno alle
pareti interne corre una balconata, che sarà adibita a galleria.
Vanno le migliori lodi ai signori Di Silvestro e Di Michele per
la loro iniziativa, e facciamo ad essi i più fervidi auguri. La
sala sarà probabilmente inaugurata nel prossimo mese"(1).
Difatti il 28 febbraio viene inaugurato il nuovo
cinematografo Iris con un banchetto, allestito nei
medesimi locali, al quale parteciparono molti invitati che con
affettuose parole augurali e brindisi approvarono allegramente
l’evento ed ai quali si aggiunse il Concertino di Pescara
che allietò il festeggiamento eseguendo scelti brani da ballo.
Il prof. Antonio Di Silvestro ringraziò tutti con "un vibrante e
poetico discorso, nel quale accennò all’utile insegnamento che
il popolo ritraeva dal cinematografo", discorso che era stato
fatto stampare dalla tipografia Verrocchio in un elegante
cartoncino e distribuito come ricordo a tutti i commensali (2).
|
|
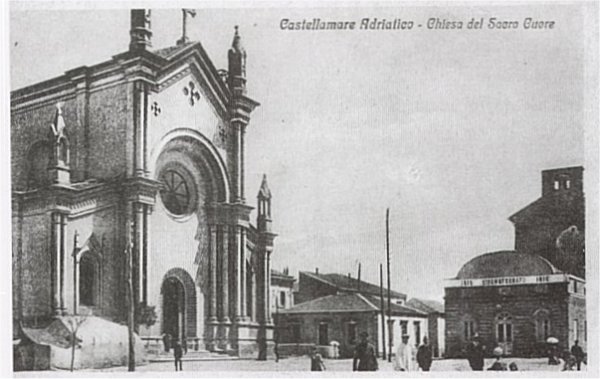 |
|
Il cinematografo
Iris in una cartolina d'epoca |
|
|
La
cronaca, nei mesi successivi, registra un grande
successo di pubblico per la scelta e per la qualità
delle prime proiezioni cinematografiche, definite
"di una fissità e lucentezza inappuntabili", per le
operette e per gli spettacoli musicali come quello
tenuto dalla Scuola Orchestrale intercomunale di
Pescara-Castellamare, istituita e diretta dal
maestro Rodolfo Luise e che, tra l’altro, era stata
lodata da Gabriele D’Annunzio. Il gradimento
popolare era dovuto anche alla centrale posizione
della sala Iris in Piazza Sacro Cuore che,
quale ritrovo "veramente delizioso", contribuiva ad
accrescere il decoro della cittadina nel suo pieno
sviluppo demografico.
Durante
l’estate dello stesso anno veniva riaperta anche la
sala Eden, ubicata nel rione marino, ed
entrambe le sale offrivano spettacoli di varietà e
rivista con la Compagnia comica napoletana
Donizetti-Cafaro, con le chanteuses, il
macchiettista D’Ambrosio e con la troupe
Florents (3).
Dalla stagione
autunnale del 1910 l’attività della sala Iris
ha una battuta d’arresto poiché non si rilevano
notizie sino al 4 giugno del 1911 quando si
ripropone al pubblico con il nuovo nome di Sala
Margherita. Vi operavano compagnie di prosa, di
varietà, contorsionisti, saltatori, illusionisti ed
artisti dai generi più differenti mentre, per la
stagione di Carnevale del 1912 vi si organizzavano
molti veglioni. Le rosee aspettative degli esordi
sembrano però essere svanite ed anche se la
partecipazione della cittadinanza è sempre numerosa,
la caratteristica degli spettacoli era divenuta
qualitativamente meno rilevante e non si parlava più
di proiezioni cinematografiche. L’interesse del
prof. Di Silvestro si era diretto ad altro, dapprima
alla sala Eden ed in seguito al teatro
Excelsior che si imporrà per il suo maggior
livello artistico.
È il 6
febbraio del 1913 quando, dalle pagine della cronaca
de’ Il Popolo Abruzzese si apprende che, "rimessa
completamente a nuovo ed ampliata in modo ammirabile
a cura di una benemerita società cittadina con a
capo il dott. Pandolfi" è stata riaperta al pubblico
la Sala Margherita col nuovo nome di
Teatro Sociale (4).
A questo
punto è opportuno aprire una breve parentesi circa
la predetta impresa teatrale della quale faceva
parte Carlo De Filippis Delfico, figlio del
musicista e geniale pittore caricaturista Melchiorre
(Teramo, 26 marzo 1825 - Portici, 22 dicembre1895) e
di Concetta Sposito (Napoli, 9 dicembre 1843 -
Portici, 8 dicembre 1889). Carlo, terzogenito di
dieci fratelli, era nato a Portici il 24 gennaio
1867, aveva sposato a Napoli il 2 aprile 1885
Vincenza Catena (Napoli, 6 marzo 1867 - Pescara, 20
dicembre 1944) e dal matrimonio erano nati
Melchiorre, Concetta e Giuseppe Mario e, a
Montesilvano, Ettore, Orazio, Fernando e Armando
(5). Carlo, infatti, tra la fine del 1891 e l’inizio
del 1892, come risulta dalle liste elettorali, con
tutta la sua famiglia e con la sorella Celeste era
partito da Napoli alla volta di Montesilvano, dove
vivevano i fratelli del padre, Troiano e Filippo De
Filippis Delfico ed altri numerosi parenti. Non si
conosce per quale causa Carlo abbia lasciato Napoli,
è ipotizzabile però che il motivo potrebbe essere
stato quello di occuparsi dei beni che il padre
Melchiorre aveva ereditato alla morte dei genitori
Gregorio De Filippis e Marina Delfico e che, in
massima parte, si trovavano nella cittadina
abruzzese. Tale ipotesi è supportata dal fatto che
Carlo, negli atti dello stato civile dei figli che
nascono a Montesilvano, è definito "gentiluomo
proprietario". Non si hanno notizie sulla giovinezza
di Carlo ma, l’aver aderito ad una società teatrale,
fa pensare che a Napoli avesse maturato una qualche
esperienza in questo campo o avesse ereditato dalla
ecletticità del padre Melchiorre l’interesse per
l’arte e per la musica. Ora, come già si è asserito,
nel 1913 entra a far parte della società che
amministrava il Teatro Sociale, attività che
si avvia subito con un buon successo. La cronaca
della stagione di carnevale ci riferisce di
animatissimi veglioni e del debutto della valente
compagnia romana di operette "Alfredo Fabrini" con
La vedova allegra (6). La stessa compagnia
rappresenta quindi La mascotte, un'opera
buffa di Edmond Audran, applauditissima per ilarità,
I Granatieri, operetta del M° Vincenzo
Valente, le Campane di Corneville, opera
comica di Clairville e Gabet, musicata da R.
Planquette, il Sogno di un valzer di Oscar
Strauss, La Geisha di S. Jones ed infine
Il Conte di Lussemburgo di Franz Lehar.
Il teatro era sempre gremito ed il pubblico
apprezzava con entusiasmo sia i protagonisti, tra i
quali il soprano Z. Fabrini, il tenore V. Trabucco e
il baritono C. Corti, sia il gradevole allestimento
scenico e l’orchestra. Unica nota stonata scrive,
meravigliandosi, il cronista era "…l’assenza della
parte migliore di Castellamare, la quale dovrebbe
aiutare moralmente e materialmente una istituzione
diretta a dare una necessaria educazione artistica
alla cittadinanza" (7). Le programmazioni proseguono
tra serate dedicate alla musica lirica con le
esibizioni della coppia Gargano o con spettacoli di
più facile ascolto rappresentati dal trio Flores,
alternate a proiezioni cinematografiche di
lungometraggio e di assoluta novità.(8). Nel mese di
maggio del 1913 si esibisce in teatro la compagnia
drammatica Rossi-Girola che, all’epoca, doveva avere
una certa notorietà considerando gli elogi della
stampa rivolti non solo a tutti i protagonisti, ma
anche "all’ottima messa in scena ed allo splendido
vestiario". Il repertorio ritenuto "modernissimo"
era costituito dalla tragedia La Fiaccola sotto
il moggio di Gabriele D’Annunzio, dai drammi
Il cardinale di Louis Napoleon Parker, La
moglie del dottore di Silvio Zambaldi e La
Fiammata di Henry Kistemaekers.
Nella
serata d’onore della prima attrice Adalgisa Rossi
Girola il teatro, gremito da un "pubblico scelto",
applaude con entusiasmo La figlia di Iorio,
tragedia in tre atti di G. D’Annunzio. L’attrice nel
ruolo di Mila di Codra, "eseguì con stupenda
assimilazione e commovente maestria le difficoltà
della parte, per la quale il pubblico restava
addirittura suggestionato… I modi attraenti, la
naturalezza d’espressione, che è sublime negli
scatti di dolore, di gelosia e di ripugnanza
conquistavano l’animo dell’uditorio…" scrive il
giornalista che non risparmia plausi agli altri
interpreti tra i quali Felice Girola nel ruolo di
Aligi. All’inizio della stagione estiva arrivano
al Teatro Sociale Les Mayer, eccentrica e
giovane coppia esibitasi nei primissimi
caffè-concerto dotata di talento che, arricchita da
splendidi costumi, presentava ogni sera un nuovo
repertorio di canzonette, macchiette e duetti
accompagnata al pianoforte dal M° Ugo Palombi.
Naturalmente non mancavano le proiezioni
cinematografiche, anch’esse originali con le quali,
il cronista si augurava che il pubblico di
Castellamare "scacci l’inerzia e si desti dal
letargico sonno da cui per la lunga invernata è
rimasto oppresso" (9).
L’impegno
della società amministratrice del teatro era sempre
diretto a dare spettacoli sorprendenti ed
allettanti. E’ la volta, nel pieno dell’estate, del
Trio Marchetti-Cacini con romanze, melodie e duetti.
I momenti comici di Gustavo Cacini riuscivano
spassosi mentre le esibizioni della "canzonettista"
Mirra Principi erano molto apprezzate. Le serate si
concludevano con programmi cinematografici che
avevano raggiunto un buon livello, grazie al giovane
operatore anconetano Carlo Casaretto il quale
"possiede una tale raffinatezza nell’arte che
guardando il quadro è come guardare il vero:
l’occhio non si stanca affatto poiché il quadro è
fermo e pieno di luce" commenta sempre N. Onined
sulle pagine de’ Il Popolo Abruzzese (10).
Trascorrono alcuni mesi e il 24 novembre 1913 il
giovane Carlo Casaretto sposa Maria Concetta De
Filippis Delfico figlia di Carlo, una cerimonia
molto partecipata dalla cittadinanza di Castellamare
con un grande tributo di simpatia (11). Intanto il
primo dicembre al Teatro Sociale va in scena,
dopo una lunga attesa, la primaria Compagnia di
operette diretta da Gaetano Martinez che si era
esibita nei migliori teatri. Rappresentano La
casta Susanna di Jean Gilbert, una nuovissima e
applaudita produzione nella quale si distinguono,
tra gli altri, i soprani Edwige Warney, Teresa
Fulignoli e Ida Venturi, i tenori Gino Zelaschi e
Trabucco e gli affiatati cori, l’unica critica era
rivolta all’orchestra perché composta, a dire del
cronista, da pochi elementi ma che aveva assolto
comunque, in maniera soddisfacente, il proprio
ruolo. Il repertorio delle successive serate
prevedeva La principessa dei dollari di Leo
Fall, Il conte di Lussemburgo di Franz Lehar
e La reginetta delle rose di Ruggero
Leoncavallo. Il successo degli spettacoli e
l’indubbio talento della compagnia, che poi si
sarebbe diretta al Teatro Comunale di Teramo,
permettono alla Società teatrale di ricevere molti
consensi (12). Le testimonianze relative
all’attività del Teatro Sociale per l’anno
1914 sono veramente poche. La prima, riportata da Il
Popolo Abruzzese il 14 luglio ci riferisce che la
società amministratrice del teatro si è sciolta e
Carlo De Filippis Delfico è rimasto unico
socio-proprietario, notizia questa che fa intendere
una qualche difficoltà nella gestione del pubblico
locale. Il cronista comunque scrive che "questo
ottimo ritrovo è sempre popolato di canzonettiste,
macchiettisti, duettisti, oltre alle splendide
pellicole cinematografiche presentate ed apprezzate
dal pubblico…". In quel periodo vi operavano le
sorelle Bonheur e si aspettava, nelle sere
successive, il debutto della celebre Renata Carpi
definita "una stella del firmamento del varietà" di
primo Novecento (13).
Il 6 gennaio del 1915 la
cronaca del giornale riferisce dello strepitoso successo riscosso dalla
proiezione delle pellicole Peppeniello, ispirata ad un episodio
della rivoluzione napoletana del 1820 e Senza famiglia, tratta
dal romanzo di Hector Malot.
Ma il 17 gennaio 1915 le
pagine de’ Il Popolo Abruzzese sono in gran parte occupate dalla notizia
del terribile terremoto che, alcuni giorni prima, precisamente il 13,
aveva distrutto Avezzano e tantissimi altri centri della Marsica
causando oltre 30.000 vittime. Molti feriti erano giunti in treno anche
a Castellamare dove tutta la popolazione si era prodigata
nell’accogliere e curare i terremotati. La villa De Felici veniva
trasformata in un comodo ospedale come pure il padiglione marino, gli
alberghi e le case private. Ammirevoli per i soccorsi, oltre a tutti i
medici del luogo, erano stati molti giovani e tra questi viene elogiato
per l’opera infaticabile Melchiorre, primogenito di Carlo De Filippis
Delfico che, a sua volta, destinava alla causa umanitaria l’incasso
raccolto nelle tre serate in cui, presso il suo locale, si sarebbero
proiettate alcune pellicole cinematografiche tra le quali Il delitto
dell’altro.
Seppur il doloroso evento
sismico continuava a turbare gli animi della popolazione, l’attività
teatrale prosegue tra veglioni, operette e proiezioni di film mentre,
per la gestione degli spettacoli, il dott. Pandolfi torna ad affiancare
il De Filippis Delfico. Nel maggio dello stesso anno si ripropone a
Castellamare la Compagnia Martinez con l’allestimento dell’operetta
Eva di Franz Lehar ed anche questa volta, composta da valenti
artisti tra i quali la protagonista Amelia Ferruccio, ottiene numerosi
consensi soprattutto da parte del pubblico più competente (14).
Il 23 maggio del 1915
l’Italia entra nel conflitto mondiale e sarà l’inizio di un lungo
periodo denso di difficoltà e di sofferenza.
Mancano informazioni su
quanto avviene nel Teatro Sociale sino al 25 luglio quando un
trafiletto del giornale reca il seguente annuncio: "Come già si sapeva,
la nuova impresa, formata esclusivamente dal Sig. Carlo De Filippis
Delfico, ha voluto cambiare il nome al suo teatrino in Cinema
Teatro Olympia dappoichè, allontanatisi tutti gli altri soci,
era rimasto solo. Questa sera vi è l’insuperabile film di m. 1200 dal
titolo La grande guerra europea divisa in tre parti" (15).
|
|
|
|
|
Il cinematografo Olympia in una cartolina d'epoca |
|
|
|
Pur in mancanza di notizie è
possibile supporre che presso l’Olympia si continuino a dare
spettacoli e proiezioni ma si dovrà attendere il 19 marzo 1916 per
leggere sulle pagine del settimanale Vita Abruzzese l’avviso che presso
il teatro "… gentilmente concesso avrà luogo la pesca di beneficenza del
Posto di Ristoro per i militari malati o feriti di passaggio nella
stazione di Castellamare Adriatico … tra i doni pervenuti al Comitato
primeggiavano quelli delle LL. Maestà la Regina e la Regina Madre che
costituivano una tale attrattiva da assicurare la buona riuscita della
festa …".
A maggio dello stesso anno la
stampa reca tale annuncio: "All’Olympia, il proprietario Sig.
Carlo Delfico, per rompere la grande monotonia che invadeva questa
città, ha chiamata l’ottima e conosciuta Compagnia drammatica italiana
Fratelli Marchesini, che vi agisce da diverse sere riscuotendo
seralmente calorosi e meritati applausi…" soprattutto con la messa in
scena di Fedora, dramma del francese Victorien Sardou
(16).
La guerra faceva sentire i
suoi effetti tanto che per il 1917, dalle cronache locali, si ha
un’unica notizia riguardo all’attività dell’Olympia. E’ estate e
in teatro va in scena una brava Compagnia di varietà guidata "dal comico
Brugnoletto, un tipo romano autentico - scrive l’articolista - e diretta
con perfetto senso d’arte dal valente cav. prof. Morale, profugo
triestino ed autore di un magnifico Inno di guerra molto gradito
da S. M. il Re, … A questi fanno degna corona eleganti canzonettiste fra
le quali primeggia Grisette fine melodista e poi la De Giorgis, la
Ginette, la Berger quest’ultima professoressa di uno strumento delicato
e poco comune alle signorine, il flauto che suona in modo
impareggiabile. L’orchestrina sotto la magica bacchetta del prof. Morale
fa prodigi, e nell’insieme lo spettacolo merita di essere onorato di un
pubblico più numeroso". Nel contempo si da l’annuncio che in teatro,
nelle successive serate, si proietterà Il cuore d’Italia – Visioni e
palpiti, un film che a Roma aveva destato del fanatismo (17).
Proseguendo nel racconto delle vicende del cinema teatro Olympia
nel febbraio del 1918 si pubblicizza un "capolavoro di F. Russo della
Fausta - Film" dal titolo Le memorie di un pazzo mentre
per aprile lo spettacolo prevede il film La sposa della morte ed
un Concerto-varietà della Tournée Lepri - Ortiz. Nel mese di luglio
sulle pagine del giornale Vita Abruzzese si legge che "il Sig. Broglia
ha risollevato le sorti del ritrovo pubblico e sotto la gestione estiva
dell’avvenente e brava artista La Genovesi fa sì che ogni sera la sala
teatrale sia meta di tutta la cittadinanza che ama prendersi un po’ di
svago tra tante trepidazioni e tanti sacrifici". Dopo le recite della
Compagnia Rossi - Girola, i programmi della Tournée Riccio e le
proiezioni di vari film si fa pubblicità, a piena pagina, alla valente e
spettacolare Compagnia in musica di Felice Paccot.
In ottobre, infine, debutta
la Compagnia di varietà e commedie musicali Rambaldi - Gargano (18).
Siamo nel 1919. Dalla lettura dei periodici d’epoca si nota che le
proiezioni cinematografiche più o meno spettacolari e di interesse
artistico si stanno ormai affermando. Proseguono comunque le
rappresentazioni dal vivo seppur di mediocre qualità: in febbraio
"furoreggiano" la divette Gigetta e il trio danzante Corno d’Oro,
in aprile sarà la volta della Compagnia di operette Lepri - Ortiz che
propone Addio giovinezza e La vedova allegra. I commenti
del cronista non sono esaltanti. Scrive infatti: "E’ andata in scena
La vedova allegra ed ha fatto male perché la vedova Clavari tutto
aveva fuorché la voce, dote indispensabile per i lavori in musica. Di
buono vi è la signora Pia Ortiz e qualche elemento maschile. L’egregio
sig. Spartaco Lepri, poi, sarà un bravo caratterista ma ormai gli anni
anche per lui… diminuiscono come… i denti e le sue funzioni si
dovrebbero limitare a quella di ottimo Direttore". Per agosto, infine,
si attendeva il debutto della compagnia napoletana Franchi – Urciuoli le
cui aspettative erano notevoli (19).
L’undici gennaio 1920 ritorna
a Castellamare, nel teatro Olympia, la compagnia di prosa diretta
da Edoardo Marchesini, che debutta con La Volata di Dario
Nicodemi per eseguire nelle successive sere Il padrone delle ferriere
di George Ohnet, Il cardinale e La Fiammata, spettacoli
che, come precisa il cronista, divertono con diletto e moralità di cui
"la crescente gioventù ne sente in verità troppo il bisogno". Si era
precipitati, infatti, all’indomani della guerra in una profonda crisi
economica e il cosiddetto teatro di rivista un misto di
prosa,
musica,
danza
e scenette umoristiche ispirate alla semplice attualità e ai
tradizionali cliché erotico-sentimentali, uniti da un sottile filo
conduttore e dalla presenza di personaggi fissi come la
soubrette,
era alquanto decaduto. Complice ne era la veloce affermazione del cinema
cosicché il varietà, per sopravvivere, andava modificandosi in
avanspettacolo ossia in quelle brevi rappresentazioni, non prive di
brio, che anticipavano le proiezioni. A tal proposito, nel febbraio del
1920, si annunciano una serie di film interpretati dalle "più avvenenti
e preferite regine della scena muta", tra i quali emerge "l’emozionante
capolavoro drammatico" L’agguato della morte.
Il 15 marzo, per la stagione
primaverile di prosa, Luigi Ballerini, direttore del settimanale Vita
Abruzzese, nel comunicare con enfasi l’arrivo della Compagnia Drammatica
Italiana di Armando Pizzigati esclama: "Finalmente respiro! Dopo molti
mesi di parecchie Tournée di varietà e di attrazioni più o meno
decenti, di gruppi dialettali più o meno… castigati e digeribili, ecco
che sul palcoscenico del Teatro Olympia si presenta una valente,
simpatica ed elegante Compagnia di prosa italiana. E ne era tempo,
perché ormai di lazzi e di oscenità, di dialoghi sgrammaticati a
soggetto, di prodezze da bascio puorto e di fischi e di
pernacchie – mi si permetta il vocabolo sconcio – il pubblico di
Castellamare ne era ormai arcistufo e stanco, tanto che le migliori
famiglie della città da tempo avevano totalmente disertato il teatro…".
Passa quindi ad esaltare la Compagnia costituita da un gruppo affiatato
di artisti, provenienti dalla dotta Bologna che, per la loro
preparazione sin dalla prima recita, hanno destato viva ammirazione
ristabilendo sul palcoscenico "…la nobile missione di educare,
ingentilire, commuovere e divertire in forma degna il pubblico…". Il
programma che prevedeva L’Avvocato difensore, commedia di Mario
Morais, Scampolo di Nicodemi, La morte civile dramma di
Paolo Giacometti, ebbe grande successo e non si risparmiano parole di
elogio per tutti gli artisti tra i quali oltre al Pizzigati, le signore
G. Venezze e Nardi ed i signori M. Micarelli, F. Fucigna e Ventura (20).
Le proiezioni cinematografiche prevedevano invece il dramma siciliano a
forti tinte Feudalismo e Il diritto di uccidere. Per
aprile la cronaca ripropone il ritorno del geniale e popolare artista
Brugnoletto col suo originale spettacolo di varietà e per maggio la
rinomata e valente Compagnia Drammatica Ravielli – Martini. Ma, sulla
stampa, risalta la nota critica del cronista che sottolinea la scarsezza
di pubblico presente agli spettacoli, quel pubblico che sarebbe invece
accorso numeroso se "… quattro chanteuse sguaiate e scollate"
avessero calcato la scena. Per la stagione estiva del 1920 si propongono
le proiezioni delle spettacolari avventure del ladro gentiluomo
Rocambole tratte dai romanzi del francese di Ponson du Terrail e le
comiche dell’attore Max Linder nel caffè Philibert, lavoro
parigino che si proiettava con successo nei cinema dei grandi centri.
Per l’inizio dell’autunno l’Olympia ha in programma La
canaglia di Parigi e L’inferriata della morte interpretato
dall’avvenente attrice del cinema muto Italia Almirante Manzini
realizzando il cosiddetto "pienone". La mancanza di fonti non permette
di conoscere l’attività del teatro sino al 4 giugno 1921 quando si
annuncia il debutto della Compagnia di operette L’Unica guidata
dall’esuberante e bravo artista Felice Paccot, già noto a Castellamare,
accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro De Marco di Francavilla
con l’esecuzione, tra le altre, di Parigi mia. Tanti i consensi
del pubblico che dimostra di apprezzare le doti dei diversi interpreti
tra i quali il soprano Carmen Storari e il tenore Tommaso Cisternino.
Oltre ai commenti teatrali, tra le note del giornale si legge che Carlo
Delfico (sic ma De Filippis Delfico) ha in programma il restauro
dell’Olympia per renderlo più elegante e più comodo, dotandolo
anche di un eccellente buffet dove il pubblico potrà trascorrere
allegre serate così da evitare la "monotonia del cinematografo". Il
Panzini nel riportare la notizia si congratula col Delfico per l’ottima
idea che spera di vedere realizzata nel più breve tempo possibile (21).
Com’è ormai consuetudine non
mancano i film, sono in visione Le isole insanguinate e le due
serie delle Notti Rosse mentre si attende il varietà del Duo
Felios. "Ma gli affari sono magri - scrive il cronista - sia all’Excelsior
che all’Olympia … il caldo tropicale non invoglia né i cittadini
né i forestieri a frequentare i teatri tanto più che la musica al mare
attrae la popolazione all’aperto. - Ed aggiunge …ma ora che inizierà le
sue rappresentazioni il Circo equestre in piazza, saranno tre i ritrovi
che si danneggeranno a vicenda e, francamente, si poteva benissimo
evitare dall’autorità locale tale spietata concorrenza, specie quando
non va a beneficio di nessuno". Nel settembre del 1921 ritorna in teatro
la Compagnia Drammatica dei fratelli Luigi e Sante Marchesini con Il
Beffardo di Nino Berrini che ottiene sempre un notevole successo
seguita da quella di Giovanni Grasso Junior che, circondato da attori di
talento, ogni sera conquista il pubblico sia nel dramma che nella
commedia.
La mancanza di informazioni
non rende possibile sapere cosa avviene nel 1922. L’unica notizia è
quella del 29 ottobre quando su Vita Abruzzese si legge che la Compagnia
Napoletana Trengi - Petito - Bonandi ha rappresentato la brillante
commedia Il medico dei pazzi, farsa in tre atti di Eduardo
Scarpetta, proprio una settimana successiva alla marcia su Roma (22
ottobre) che segnerà l’inizio del ventennio fascista che tanto influenzò
il ruolo e lo sviluppo del cinema.
Nell’aprile del 1923, dopo le
recite musicali de’ La Nova, arriva all’Olympia la compagnia
comica di prosa Tina Paterno che porta in scena nuovi spettacoli per
Castellamare mentre in ottobre la Compagnia Lirica Castelmonte,
proveniente dalle esibizioni nel teatro Marrucino di Chieti, eseguirà
tre opere liriche Lucia di Lammermoor e La favorita di
Gaetano Donizetti e Norma di Vincenzo Bellini. Mancano notizie
intorno all’attività del teatro sino all’estate del 1924, un’estate che,
come scrive il cronista, vede pochi "bagnanti" a Castellamare a causa
sia della crisi economica sia dei prezzi troppo elevati in una cittadina
ancora priva di grandi e comodi alberghi, di pensioni convenienti, di
moderne e organizzate attrattive atte a richiamare i turisti ed a
conferma di ciò, per quanto riguarda gli spettacoli, rende noto che all’Olympia
e all’Excelsior si susseguono divertenti serate di varietà, di
prosa e film non meglio specificati. Intanto, il 15 agosto dello stesso
anno, Carlo De Filippis Delfico si iscrive alla Camera di Commercio di
Teramo col n.5199 come impresa di "Spettacoli cinematografici e
teatrali" in conseguenza delle nuove norme che disciplinano tali
attività e, da questa data, scende un lungo silenzio su quanto avviene
nel teatro Olympia.
Sono questi gli anni in cui,
sopite le annose discordie tra Castellamare Adriatico in provincia di
Teramo e Pescara in provincia di Chieti, negli amministratori del tempo
matura l’idea di riunire i due comuni, divisi nel 1806 durante
l’amministrazione napoleonica, per avere maggiori possibilità di
sviluppo soprattutto dal punto di vista economico. Così con il sostegno
dell'autorità politica del ministro abruzzese
Giacomo Acerbo
e del prestigio di
Gabriele
D'Annunzio il 2 gennaio 1927 Pescara viene elevata a
provincia annettendo Castellamare Adriatico che perderà il comune e il
toponimo. In questa nuova realtà l’11 settembre 1927 è il settimanale
L’Adriatico ad annunciare brevemente che "l’Olympia, tornato
sotto la gestione di Carlo Delfico dà sempre spettacoli cinematografici"
e da questo momento in poi, difatti, stando alle programmazioni
riportate sul citato settimanale, si annunceranno esclusivamente
proiezioni di film allora in voga: dai western ai mitologici, da quelli
di guerra ai comici (22).
Nell’edizione del 26 gennaio
del 1930 de’ L’Adriatico si legge che la sezione provinciale di Pescara
dell’Opera Nazionale Dopolavoro, associazione creata nel
1925
dal
regime fascista
col compito di occuparsi e programmare il tempo libero dei lavoratori,
ha stipulato una convenzione con la Federazione Industriale Fascista
della provincia di Pescara concernente la riduzione da accordarsi ai
"dopolavoristi" nei teatri e nei cinematografi esistenti nel comune pari
al 30% sul costo del biglietto col seguente calendario: lunedì e venerdì
all’Excelsior, martedì e giovedì al Pomponi, mercoledì e
sabato all’Olimpia, lunedì e giovedì al Michetti con
l’obbligo, per le ditte associate, di rispettare quanto convenuto (23).
D’altra parte è noto che il Fascismo pose grande attenzione al controllo
della cultura e in particolar modo del cinema, considerato un ottimo
mezzo di propaganda e un efficace sistema per il controllo della
popolazione. Si moltiplicarono le aperture di sale cinematografiche ed
anche la loro stretta vigilanza con periodici monitoraggi sulla
gestione, sugli spettacoli, sugli orari. In un documento conservato
presso l’Archivio di Stato di Pescara nel fondo Prefettura e
datato 24 ottobre 1935, sono elencati tutti i teatri della provincia, il
nome della sala, il gestore, la categoria e il numero dei posti (24). In
questo atto si legge che l’Olimpia è sempre di Carlo Delfico, è
di terza categoria ed ha 328 posti, mentre dal Catasto si evince
che l’edificio, situato in Piazza Vittorio Emanuele al n. 20, costruito
da Panfilo Di Michele viene acquistato nel 1928 da Giovanni e Tullio
Cecamore di Achille, con atto del notaio Fusilli di Pescara (25).
Da questo momento non si
hanno più notizie circa la gestione del cineteatro e se, dopo la
scomparsa di Carlo De Filippis Delfico nel 1940, sia stata portata
avanti da qualche familiare.
Per concludere la narrazione
delle "vicissitudini" del teatro Olimpia si riporta uno stralcio,
tratto dall’articolo di Giuseppe Quieti, pubblicato su Il Messaggero
dell’8 settembre 1988 dal titolo "Formidabili quegli anni".
L’autore ripercorre col pensiero i tempi andati, luoghi, situazioni e
personaggi della Pescara degli anni trascorsi e scrive "… Siamo diretti
al cinema Olimpia meglio conosciuto come ‘il Pidocchietto’… ma vi
avevo promesso un’altra specialità a buon mercato, e allora, prima di
entrare, compriamo qualcosa alla bancarella (un carrettino) della
vecchietta che, davanti al cinema, vende ceci e fave abbrustolite…
squisite. Ma bisogna consumarle dentro il cinema, c’è più gusto, mentre
si guardano due films (uno è certamente un western con Buster Crabbe).
Una raccomandazione importantissima: o andate in galleria o, se questa è
piena, come accade normalmente, e siete costretti a stare in platea, non
vi sedete in quelle due file vuote al centro della sala. Come vedete c’è
il pienone, molti spettatori stanno in piedi ma due file sono vuote.
Sono quelle sotto la balconata della galleria da dove piovono, senza
sosta, bucce di fave e qualcos’altro degli spettatori delle prime file
della galleria. Se, uscendo dal cinema avete sete (ceci e fave mettono
sete) c’è, a pochi passi, l’osteria dei ‘Sette nani’… Quell’angolo di
Pescara intorno alla chiesa del Sacro Cuore resiste ancora in parte. La
vecchietta (Genoveffa si chiamava?) dei ceci e delle fave è scomparsa da
molti anni; l’osteria dei ‘Sette nani’ più di recente, ma il cinema c’è
ancora. Oggi si chiama Centrale. E’ un cinema rinnovato ma con
una certa aria di dolci nostalgie. Ne è passato di tempo…"(26). E, sulle ceneri del
Centrale, abbattuto nell’estate del 2001, sorgerà un palazzetto di
vetro che, oggi, ospita la libreria Feltrinelli.
|
|
Il palazzetto che ospitava il cinema Centrale |
|
_______________ |
|
(1) Biblioteca
Provinciale "M. Delfico" Teramo, (d’ora in poi B.P.M.D.), Il Faro, 27
gennaio 1910.
(2) B.P.M.D.,
Ibidem, 6 marzo 1910.
(3) B.P.M.D.,
Ibidem agosto-settembre 1910.
(4) B.P.M.D.
Il Popolo Abruzzese, 6 febbraio 1913, a. II, n.50.
(5) Per
maggiori dettagli sulla discendenza genealogica di Carlo De Filippis
Delfico cfr. www.defilippis-delfico.it
(6) B.P.M.D.,
Il Popolo Abruzzese, 22 febbraio 1913, a. II, n.54.
(7) B.P.M.D.,
Ibidem, 26 febbraio e 1 marzo 1913.
(8) B.P.M.D.,
Ibidem, 19 aprile 1913.
(9) B.P.M.D.,
Ibidem, 11 giugno 1913.
(10) B.P.M.D.,
Ibidem, 15 luglio 1913.
(11) B.P.M.D.,
Ibidem, 3 dicembre 1913.
(12) B.P.M.D.,
Ibidem,17 dicembre 1913.
(13) Una immagine di Renata Carpi trovasi sul sito
www.avellinesi.it/RENATA%20CARPI.htm
(14) B.P.M.D.,
Il Popolo Abruzzese, 13 maggio 1915.
(15) B.P.M.D.,
Ibidem, 31 luglio 1915.
(16) B.P.M.D.,
Ibidem,13 maggio 1916.
(17) B.P.M.D.,
Vita Abruzzese, 11 luglio 1917.
(18) B.P.M.D.,
Ibidem,21 luglio 1918.
(19) B.P.M.D.,
Ibidem, febbraio-aprile-agosto 1919.
(20) B.P.M.D.,
Vita Abruzzese, 11 luglio 1920.
(21) B.P.M.D.,
Ibidem, 11 luglio 1921.
(22)
Biblioteca Provinciale "G. D’Annunzio" Pescara, L’Adriatico, 11
settembre 1927.
(23)
Biblioteca Provinciale "G. D’Annunzio" Pescara, Ibidem, 26
gennaio 1930.
(24) Archivio
di Stato Pescara, Prefettura, b.63.
(25) Archivio
di Stato Pescara, Ufficio Tecnico Erariale
Pescara - Catasti.
(26) B.P.M.D.,
Il Messaggero, 8 settembre 1988. |
|
-----
~ ----- |
|
Un sentito grazie per la preziosa collaborazione a Fausto Eugeni e
Franca Saraullo. |
|