|
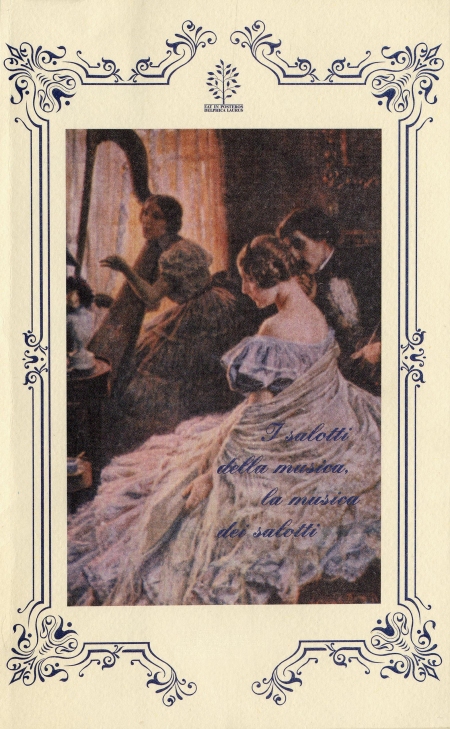 |
|
I salotti della musica, la musica
dei salotti |
"In Teramo una nobile donna raccoglieva nel suo palazzo secentesco [sic],
ricco di opere d'arte e di un magnifico giardino pensile, i cittadini
notoriamente avversi al regime borbonico; ed era la contessa Marina
Delfico, ultima della sua stirpe, vedova di Gregorio de Filippis, conte di
Longano, e madre di Trojano e di Filippo, esuli in Grecia e in Francia, e
di quel Melchiorre juniore, spirito di fine caricaturista, del quale si è
parlato in altra parte di questo libro. Nelle sontuose sale del palazzo
Delfico, dove morì il grande Melchiorre, e dove si accede per una scala
addirittura regia, convenivano Vincenzo Irelli, che fu il sindaco della
rivoluzione, e poi fra i primi senatori del regno d'Italia; Berardo e
Settimio Costantini, Francesco e Berardo Bonolis, l'abate Quartapelle,
Giuseppe Antonio Crocetti, Stefano de Martinis, protettore della Milli,
Niccola Forti, Giovanni de Benedictis, letterato e poeta, e le famiglie
Ginaldi, Pompetti, Valentini, Michitelli. Prima del 1848 avevano
frequentato l'ospitale casa dei Delfico il Gammelli, i fratelli
Bucciarelli, uno dei quali morì pure nel bagno di Pescara; e Michelangelo
Forti, prete liberale di gran cultura e carattere eroico, morto nella
galera di Nisida. Ricordo pure Pasquale della Monica, pittore napoletano,
andato a Teramo col conte di Longano, e padre dell'insigne artista, che
conobbi a Teramo nell'ottobre scorso, quando vi fui ospite dei giovani
conti Delfico, figlio del defunto senatore e degni discendenti dell'ultimo
degli Enciclopedisti. Appresi particolari curiosi circa la vita di Teramo
di allora. Le riunioni in casa Delfico finirono nel 1857 [recte
1867], quando morì la contessa. Si ricorda che la serata caratteristica
era quella di mezza quaresima, quando si segava la vecchia, dopo la
lettura del testamento, che veniva fatta con comica serietà dall'avvocato
Carlo Ginaldi; col qual testamento la vecchia lasciava, prima di
morire, graziosi e ricchi ricordi agl'invitati. Si riceveva in casa del
ricevitore generale Ciotti, ma vi andavano più uomini che donne, e così
pure ai suoi non dimenticati pranzi; si faceva un po' di musica in casa
Ferraioli; ma, tutto compreso la vita sociale era povera cosa. Poiché la
città aveva pessima illuminazione, non era permesso girare, dopo le otto
di sera, senza una piccola lanterna, e su chi trasgrediva piovevano
legnate o minacce. Benché il teatro in legno fosse angusto e pericoloso,
aveva due stagioni molto frequentate e brillanti: prosa nell'autunno e
musica nel carnevale, e portava il nome dei proprietari Corradi e Gatti.
Il bel teatro di oggi fu costruito nei nuovi tempi. Era capo urbano
Beniamino Rozzi, figlio di un giudice regio di Notaresco, borbonico
fierissimo; l'ultimo intendente Morelli fu uomo egregio e funzionario
intelligente, e punto intinto di pece reazionaria, tanto che i borbonici
più facinorosi lo denunziarono più volte al re. L'ultimo generale
comandante la provincia si chiamava Veltri, e non era né carne, né pesce;
e il vescovo don Michele Milella, frate domenicano, godeva molte simpatie.
In quegli anni Teramo esultava per i trionfi della sua concittadina
Giannina Milli, nata da povera gente, e che si affermava improvvisatrice
illustre in tutta Italia. In Teramo vi era infine una specialità, che va
ricordata: quella di due farmacie politiche, una considerata il centro del
partito borbonico, condotta da don Nicola Ruggieri, brav'uomo e
professionista intelligente; e l'altra di don Giuseppe Antonio Crocetti,
sotto il portico del Comune, centro del partito liberale. Il Crocetti
aveva fama di chimico sapiente e anche di filosofo" (1).
A oltre un secolo di distanza, l'eloquente e pittoresca cronaca di
Raffaele de Cesare tramanda in veste letteraria la descrizione di un
particolare aspetto della vita culturale teramana dell'Ottocento.
Dipinta a caldi toni, la scena cittadina è ambientata in quei domestici
luoghi che costituirono il fulcro vitale della discussione politica,
dell'attività culturale e dell'aggregazione sociale, ed è animata da quei
personaggi che ne furono gli insigni protagonisti. Infatti, accanto ai
tradizionali pubblici luoghi di trattenimento – teatro d'opera e sala da
concerto -, il salotto privato, oltre che costituire motivo d'incontro e
di svago, rappresentò l'ideale mediazione tra le esigenze sociali di un
ceto dominante che oramai omologava nobiltà e borghesia e un linguaggio
musicale contestualmente plasmato secondo idee e comportamenti
consolidati.
Dal salotto, paradigma di una società in miniatura, il dialogo politico e
quello letterario, la mondanità o il pettegolezzo, le discussioni d'arte
come il raffinato compiacimento tra l'ascolto di una poesia o di una
languida melodia, migrando di casa in casa raggiungevano immancabilmente
l'orecchio attento dei cronisti locali che con impeccabile puntualità ne
riferivano settimanalmente nelle accattivanti rubriche dalla superba
intestazione "hight-life"… "Si va. La corte del palazzo Delfico è già un
ridente giardino; alberi, fiori, viali; una fontana manda in aria, molto
su, zampilli d'acqua, che mettono i brividi a Bacco […] E' stupenda
davvero!... La grande scala del palazzo, opera egregia ed ammirevole di
architettura, è artisticamente illuminata. Gl'invitati la saliscono tra un
torrente di luce, per essere accolti con la più squisita gentilezza e
cordialità dai socii, deputati a quell'ufficio […] In un salotto, tra le
due sale da ballo addobbate, ed illuminate con gusto ed eleganza, è posta
la musica. […] Giunge il conte Delfico con la famiglia, si levano
fragorosi ed unanimi applausi. Luisa Marcosignori e le altre della
deputazione offrono alla contessa un bel mazzo di fiori; l'egregio nostro
amico Orazio Albi, legge: Fiori modesti alla nobil donna la Contessa
Bianca Delfico. E' una poesia ispirata, e diffonde una soave
malinconia, che giunge al colmo, chiudendo con i versi: E queste foglie
che un bel verde imbruna / Aimè cadranno domani ad una ad una / Non
l'affetto morrà di chi c'invia / Fior di modestia, fior di leggiadria.
Applausi vivi e prolungati. La contessa con nobil parole ringrazia il
poeta; e noi stringendo la mano al prof. Sinigallia, è un vecchio
patriota, gli diciamo, che teco sinceramente si rallegra e ti fa plauso"
(2).
A onor del vero, la raffinata penna del nostro cronista riferisce su
un'occasione non squisitamente salottiera ma su un evento di più ampio
respiro che, pur infrangendo i canoni intimistici del genere, vi si
inserisce come pendant nel quale i tratti e le caratteristiche del
"far salotto" sono comunque conservati e rispettati.
La tradizione salottiera di stampo locale, infatti, si identifica
maggiormente con quella consuetudine di gusto borghese in cui accanto alla
causerie e al dibattito impegnato coesistono le forme più delicate
della musica vocale e strumentale insieme a quelle più disinvolte della
musica da ballo: "Dunque, il nostro amico [avvocato Alessio De
Berardinis], libero pensatore, (per chi nol sappia caldo ammiratore di
Hegel) ci ha regalato una sera di geniale passatempo. Alla otto p.m. già
le note del pianoforte echeggiavano sotto le arcate volte delle sue
stanze: alcune signorine passeggiavano a braccetto dei loro cavalieri,
allegramente cicalando: qualche bigio papà in un appartato gabinetto, ove
carte di giuoco si trovano, scacchiere e persino gl'innocenti giochi delle
dame, leggeva la Gazzetta d'Italia, l'Opinione e che so
altro. Ma lasciamo da parte la politica, che, come il sale nelle minestre,
oggi vuol far capolino dappertutto, e tiriamo innanzi. Waltzer, waltzer si
bisbiglia: nò, nò, polka, marzuka,…quadriglia invece dice qualcuno, poiché
abbiamo uno che tanto gaiamente le comanda nel sempre giovane ed allegro
Giudice Orsini; ma a tanti desideri tira di sgembo il maestro di
pianoforte ed accenna una marzuka. In un baleno la sala è invasa, e la
danza sotto i migliori auspici incomincia. Mentre in una stanza si balla,
in un'altra si fuma; si conversa, si giuoca! E' un colpo d'occhio
gradevole! La t'occorre alla vista un cavaliere, che, non provetto
nell'arte di Tersicore, incespica nello strascico della dama, e mormora un
pardon appena intelligibile; qua un giovane di belle speranze che è
alle prese, sganascia anzi con un sigaro Magliani, ed impreca al nuovo
ministro con tutte con tutte le Regie cointeressate: in fondo un signore
sulla quarantina, che rimprovera al compagno di tressette uno sbaglio
madornale; insomma tanti e poi tanti diversi accidenti ti si presentano,
che c'è da restar contentini davvero. Segue un waltzer, che passa senza
infamia e senza lode; viene poi una polka sentimentale; eccoci alla
sospirata quadriglia. La voce del Giudice Orsini suona come il fulmine di
Giove Capitolino, e, tra alcuni pasticci più o meno grossi e l'ilarità
generale, si conduce a termine il ballo. […] Or eccoli ad una nuova parte
di divertimento. Una signorina E. C., nò, voglio dir tutto, la signorina
Elvira Cellini prende posto al piano, e le sue eburnee ed agili manine
scorrono veloci sulla tastiera del clavicembalo ed Aida sospira
sotto le sue dita incarnate. L'aria dell'Egizia fanciulla Morir sì
bella e giovine affascina tutti, ma più potentemente quelli che, come
me, ebbero la fortuna di sentirlo questo capolavoro dell'immortale cigno
di Busseto. Suona anche la Mandolinata con difficilissime
variazioni la signorina, ed una salva di applausi corona alla fine la sua
provata valentia nella più simpatica delle arti. […] E da ultimo? Nulla
mancò perché tutto riuscisse bene davvero! Paste, gelati, vini a bizzeffe
erano a disposizione di tutti, sino i fiori, guardate! Che mente
provvidenziale ebbe mai quel benedetto Hegeliano del De Berardinis" (3).
Così Ipsilon firma il suo reportage: una cronaca sentita, come tutte
quelle che si potevano leggere sui due più diffusi periodici teramani, il
"Corriere Abruzzese" e "La Provincia".
Ora La bemolle, ora il corrispettivo enarmonico Sol diesis,
ora Fra-Militone, ora Furio, ora Biscroma, ora
Quattrocchi – per citare solo alcuni degli pseudonimi più intriganti
sotto cui il giornalista di turno celava la propria identità – riferiscono
sempre generosamente e con encomiabile schiettezza su ogni avvenimento
culturale cittadino, consuetudine quanto mai importante considerato che
"gli scritti sulla musica fanno parte della storia della musica come le
opere musicali, le istituzioni e la prassi esecutiva, e la forma specifica
che essi assumono in una data epoca fa parte dell'effige della storia
musicale di quell'epoca" (4).
I giornali cittadini, dunque, non trascurarono mai di rilevare ogni nuovo
evento e di valutarne, com'era d'abitudine, la qualità dell'esecuzione
musicale. Ricordiamo ad esempio l'inaugurazione della nuova sede del
Casino in casa Pompetti, in riferimento alla quale la penna impietosa e
pungente di Fra-Militone, non mancò di riportare le osservazioni
del direttore del "Corriere Abruzzese" che aveva sentenziato, rivolto
all'orchestrina, "benino, ma con balli un po' invecchiati", e di
aggiungere la sua personale esortazione: "Maestro Dati l'hai capito?
Scuotiti dal letargo!" (5).
Rammentiamo ancora il commento di La Bemolle nella cronaca di una
soirée musicale-danzante in casa Palma: "Chiusero la I parte del
trattenimento la Serenata sentimentale e la Nevrosi, Gran
Walzer di concerto, eseguite dal maestro Pepe, lavori di sua composizione.
Io son nemico delle accademie di pianoforte (sebbene sia suonatore) perché
il piano, stando la distanza del suonatore dell'istrumento, non è come il
violino, cui si può dare la espressione giusta; però sentendo il Pepe ho
dovuto ricredermi: Egli si discosta dalla comune dei suonatori di piano.
Le difficoltà sono da lui eseguite con precisione inappuntabile. Sicuro
nel tocco, composto nelle posizioni, possiede in sommo grado scioltezza,
agilità ed indipendenza delle dita, ammirevole nella mano sinistra; e ciò
contribuisce a far sentire staccato e preciso il canto, dall'accompagno e
dagli arpeggi" (6).
La citazione di questo stralcio offre, inoltre, l'occasione per attardarsi
su generi e forme del repertorio salottiero, che, nella cangiante varietà
di colori, echeggia atmosfere sentimentali, brillanti e descrittive in una
veste che asseconda al contempo le esigenze di artisti e di egregi
dilettanti. Nei salotti teramani – Ferraioli, De Petris, Ponno, Savini, De
Sanctis, Ciotti, Lucci, Sardella, Prefettura…per nominarne solo alcuni
oltre quelli altrove mentovati – i programmi musicali annoveravano tra un
table à thé e un cotillon i più bei pezzi
caratteristici dell'epoca:
"PARTE PRIMA 1. Concerto per arpa per la signorina E. Silla. 2. Fantasia
originale per pianoforte del maestro A. Cipolloni, eseguita dalla
signorina Aminta Cozzi. 3. Leggenda Valacca. Serenata del maestro
Gaetano Braga, cantata dalla signorina Amalia Ferraioli, con controcanto
di violino ed accompagnamento di pianoforte. La parte del violino sarà
eseguita dal sig. G. Pachini. 4. Sonnambula di Thomas, gran
concerto per due arpe per le signorine A. Guarducci ed E. Silla. 5.
Cavatina del Machbet di Verdi cantata dalla signorina Lucia de
Matteis. 6. Fantasia per violino sul Trovatore di Verdi eseguita
dal sig. G. Pachini.
PARTE SECONDA 7. Amore e morte, romanza per baritono sig. Leoni.
Poesia del sig. Faustino Cellini, musicata dal maestro A. Cipolloni. 8.
Ihon Thomas The Winter, pezzo caratteristico per arpa eseguito
dalla signorina A. Guarducci. 9. Intermezzo e strofe, Le parlate d'amor,
sul Faust di Gounod per la signorina A. Ferraioli. 10. Concerto per
arpa, eseguito dalla signorina E. Silla. 11. Duetto del Nabucco di
G. Verdi, cantato dalla signorina L. De Matteis e dal signor P. Q. Leoni.
12. Una lagrima sulla tomba di Meyerbeer, del Ciardi, gran
concerto per due violini, due arpe, pianoforte ed armonium, nel quale
prenderanno parte le signorine A. Guarducci, E. Silla, ed i signori A.
maestro Cipolloni, P. Q. Leoni, G. Pachini, F. De Carolis e De Petris"
(7).
Ma a quale scuola si formava la schiera delle innumerevoli e gentili
signorine, le cui manine morbide e le dita affusolate e rosee suonavano
con tanta disinvoltura e precisione da strappare i plausi dello scelto
uditorio? Chi plasmava con tanta perizia le dolci voci dei giovani
interpreti rendendole piene di grazia e di espressione? Primo fra tutti il
maestro Alfonso Cipollone, teramano di adozione, che tante energie profuse
nel dar l'avvio a una stabile istruzione musicale; e accanto a lui,
Francesco Roma, Nicola Dati, ma ancor prima Camillo Bruschelli, noto
maestro di cappella che secondo antica tradizione fu punto di riferimento
per qualsivoglia occasione musicale che abbisognasse di nuova produzione…
"al maestro Bruschelli ducati 4;00 per compenso della composizione de'
valzer e quadriglie." (8).
Quanto sinora descritto col conforto delle cronache locali, pur nella sua
brevità delinea i tratti caratteristici del mondo salottiero intimamente
connesso al lento ritmo di vita che nell'Ottocento si svolgeva nelle città
italiane. Con il modificarsi dell'uso del tempo e dello spazio, fruiti in
una dimensione sempre più accelerata e funzionale ai nuovi costumi e alle
nuove esigenze, "quando la famiglia iniziò a perdere la sua centralità
anche nel processo produttivo, quando gli spazi abitativi si restrinsero,
la casa ed il salotto borghese vennero disertati. Si iniziò ad andare "in
società" ovvero ai circoli cittadini che sorsero ovunque, alle società di
concerto, ai caffè, ai club, a teatro" (9). Questa dimensione più
allargata e democratica non negò, soprattutto in un piccolo centro di
provincia come Teramo, quell'atmosfera di gioviale familiarità che ad
esempio Giuseppe Savini, intellettuale versatile della storia culturale
teramana, seppe mantenere viva durante il suo ufficio di Presidente del
Casino di conversazione "[…] nel trattare amichevolmente coi soci e nel
desiderarne le pure, domestiche gioie; nel promuovere convegni di dolce
godimento intellettuale e feste di serena letizia; che valessero ad
affratellare vieppiù gli animi e a conservare tra le cospicue famiglie
teramane e quelle forestiere, d'impiegati la più parte, i vincoli
dell'affetto e della stima scambievoli e a formarne dei nuovi; nulla
piacendogli di più che la città se ne avvantaggiasse in gentilezza di
costumi, in dignità, in buon nome" (10).
La trasformazione delle abitudini sociali coinvolge anche la musica da
salotto che alle soglie del nuovo secolo, temperati gli accenti più
sentimentali, tesse la sua trama sonora tra le maglie di nuovi generi e
forme. Già sintesi ideale tra l'espressione musicale "colta" e "leggera",
per inevitabile metamorfosi, consegna al nuovo secolo un tesoro da cui
attingere a piene mani. Il gusto moderno potrà goderne ancora in nuove
forme e significati.
|
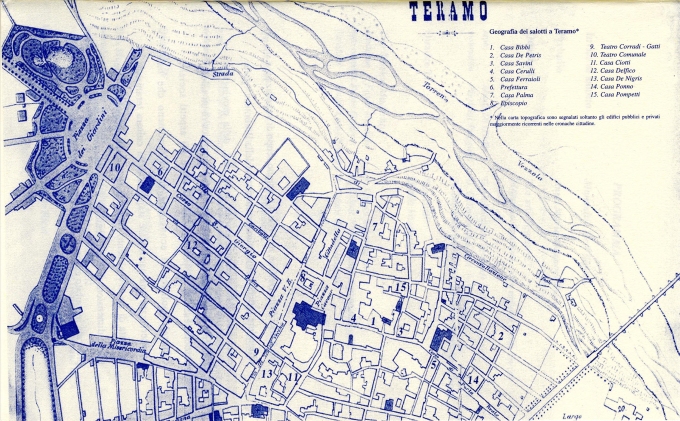 |
|
Piantina di Teramo
|
|
|
|
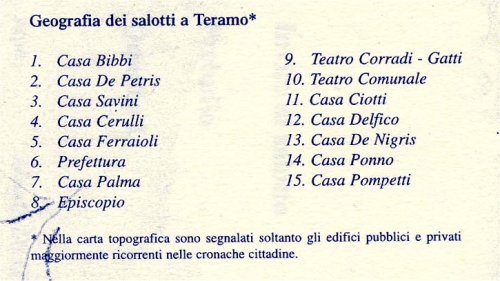 |
|
Piantina di Teramo (Particolare) |
|